
LA PAJARA
Le Pajare, conosciute anche come Paiaru, Pagghiaru, Furnieddhu, Furnu, Truddu o Chipuru a seconda della località, sono costruzioni rurali realizzate mediante la tecnica del muro a secco.
Solitamente, queste costruzioni si trovano isolate nelle campagne, sebbene ve ne siano alcune raggruppate in complessi di 2 o 3 unità per formare edifici più complessi. Oggi rappresentano uno degli elementi distintivi del paesaggio salentino e godono di tutela e valorizzazione da parte delle autorità locali.
Le Pajare sono simili ai famosi trulli: hanno forma conica a tronco e pianta circolare o quadrangolare, e sono costruite con pietre locali “a secco”, cioè senza l’utilizzo di malta o supporti. Di solito, queste costruzioni presentano una singola camera senza finestre verso l’esterno e uno spessore considerevole che garantisce un ambiente fresco anche durante i mesi più caldi. Originariamente, le pajare venivano utilizzate come rifugi temporanei o depositi (il nome stesso suggerisce un’origine come depositi di paglia), ma nel corso del tempo hanno avuto una varietà di usi, incluso l’utilizzo come residenza per i contadini durante i periodi estivi, quando si spostavano dalla zona urbana per dedicarsi alle attività agricole dal mattino al tramonto. Non di rado, all’interno delle pajare si trovano caminetti rustici, cisterne e nicchie incastonate nei robusti muri.
L’epoca esatta della loro costruzione non è nota con precisione. Probabilmente sono state edificate in epoche successive a partire dal X secolo d.C., durante l’era bizantina, utilizzando i materiali di scarto derivanti dai lavori di bonifica dei terreni agricoli. Questi stessi materiali sono stati impiegati per costruire i numerosi muretti a secco che delimitano quasi tutte le proprietà agricole del territorio circostante. Tuttavia, non si può escludere un’origine molto più antica, risalente al 2000 a.C. e alla fine dell’Età del bronzo, come evoluzione di costruzioni megalitiche come le specchie. Altre teorie, sostenute dalla somiglianza con altre strutture presenti nell’area mediterranea, suggeriscono un’importazione delle tecniche costruttive in epoche successive.
Esistono diverse tipologie di pajare, differenziate per dimensioni e modalità di costruzione. Le pajare più antiche solitamente sono di dimensioni ridotte, con un perimetro in pietra e una copertura realizzata con tronchi e frasche; successivamente si è passati all’utilizzo esclusivo della pietra. Alcune di queste costruzioni presentano un anello in pietra come rinforzo alla struttura principale, e quasi tutte sono dotate di una scala esterna per agevolare l’accesso al tetto per eventuali lavori di manutenzione.
IL BASOLO
Il basolo, noto anche come basola, è una lastra di roccia di origine vulcanica, calcarea o di un’altra pietra tenace, caratterizzata da un peso e dimensioni considerevoli (spesso di 50×50 cm o 60×60 cm). Trova impiego principalmente nelle pavimentazioni stradali.
Il termine “basolato” indica invece un tipo di pavimentazione stradale originariamente utilizzata dagli antichi Romani, che furono i primi a utilizzare basoli sia nelle strade urbane che nelle vie di collegamento tra Roma e le diverse regioni dell’Impero, al fine di garantire una maggiore fluidità nel trasporto. In quel periodo, la pietra utilizzata era la leucitite, erroneamente chiamata selce.
L’aspetto della pavimentazione varia notevolmente in base al grado di squadratura e planarità dei singoli pezzi utilizzati, che possono andare dalle semplici masse battute rinforzate con pietrame, ai basolati di ciottoli più arrotondati, fino alle vere e proprie lastre perfettamente planari e ben adiacenti. Attualmente, il termine “basolato” si riferisce comunemente alla tecnica di pavimentazione stradale adottata, a partire dai primi anni del Settecento, in tutto il Meridione, che prevede un perfetto accostamento di blocchi di forma squadrata e perfettamente planari sulla superficie della strada.
Nel secolo successivo, il basolato diventò la pavimentazione di riferimento per le piazze e le strade cittadine, e molti capitolati d’appalto contenevano dettagliate descrizioni della forma e delle dimensioni dei basoli in base all’utilizzo (marciapiede, carreggiata, canale per l’acqua).
Il materiale utilizzato per il basolato è sempre una pietra estremamente dura, che non può essere tagliata ma solo scalpellata. Spesso veniva lavorata con martellina e punte per ottenere la planarità desiderata. In ogni caso, la pietra doveva resistere all’usura causata dal passaggio di pesanti ruote di carri e carrozze, evitando la formazione di solchi sulla superficie stradale.
Negli ultimi anni, l’uso del basolato sta tornando di moda, soprattutto nel contesto dei interventi di riqualificazione dei centri storici urbani, come alternativa all’asfalto. Tuttavia, gli effetti a lungo termine di questa scelta devono ancora essere verificati.

INDIRIZZO
Strada Provinciale 79, snc
73031 Alessano Lecce
ORARI DI APERTURA
Dal lunedi al sabato 6:00 / 15:00
Domenica chiuso
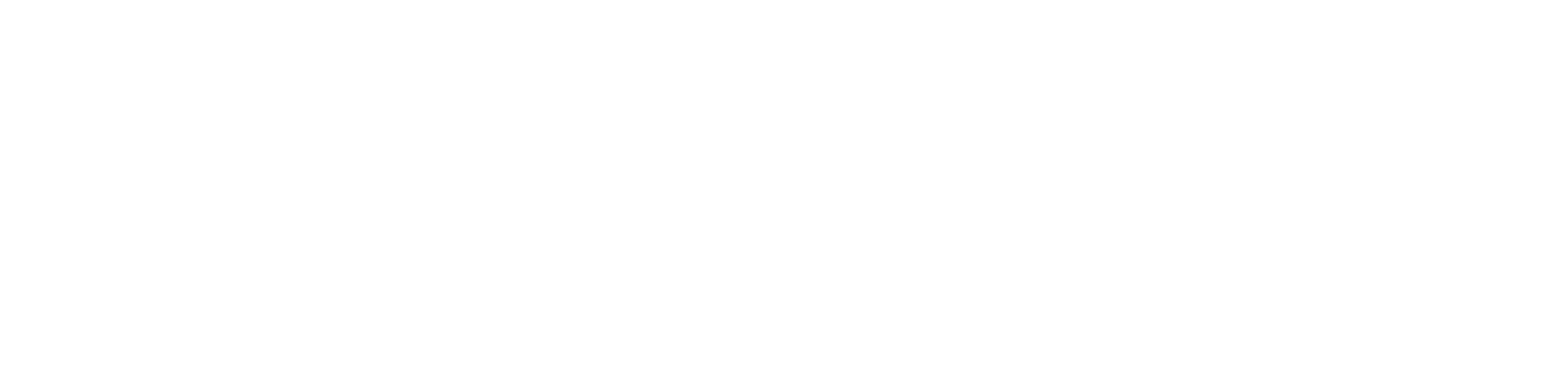
CONTATTI